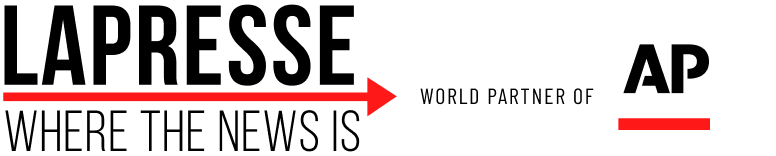Nel 2024 sono nati in Italia 369.944 bambini, quasi diecimila in meno rispetto al 2023. Il tasso di natalità è sceso a 6,3 per mille residenti, un valore che nel 2008 era di 9,7 per mille. Lo rileva l’Istat nel report “Natalità e fecondità della popolazione residente”, sottolineando come il trend negativo prosegua senza sosta dal 2008, anno in cui si registrò il massimo di nati vivi negli anni Duemila, oltre 576mila. Da allora la perdita complessiva sfiora le 207mila nascite, pari a un calo del 35,8%. La denatalità si conferma anche nel 2025: tra gennaio e luglio si contano appena 197.956 nuovi nati, circa 13mila in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-6,3%). Il tasso di natalità nell’attuale anno, secondo i dati provvisori dell’istituto di statistica, si ferma così al 3,4 per mille.
Fecondità ai minimi storici
La riduzione non è solo quantitativa ma anche demografica. Il numero sempre più ridotto di potenziali genitori, appartenenti a generazioni nate a partire dalla metà degli anni Settanta, incide fortemente sull’andamento dei dati. La fecondità media per donna nel 2024 si è attestata a 1,18 figli, con un calo costante rispetto agli anni passati e segnando un nuovo minimo storico dopo gli 1,19 figli del 1995.
Fecondità in discesa in tutte le regioni
La fecondità italiana registra un nuovo record negativo. Con 1,18 figli per donna, il 2024 si colloca al di sotto del precedente minimo storico (1,19 nel 1995). Il valore massimo del nuovo millennio, raggiunto nel 2010 con 1,44, appare ormai lontano.
Le donne straniere mantengono un tasso medio più alto (1,79), ma anch’esso in diminuzione rispetto al 2023 (1,82) e molto inferiore al 2,31 del 2010. La fecondità delle italiane è scesa a 1,11 contro 1,14 dell’anno precedente.
Geograficamente, il Centro continua a essere l’area meno fertile (1,11 figli per donna), seguito dal Nord (1,19) e dal Mezzogiorno (1,20). La Provincia autonoma di Bolzano/Bozen resta l’unica eccezione, con il valore più alto a livello nazionale (1,51). La Sardegna, invece, conferma il primato negativo con appena 0,91 figli per donna.
Le prime stime per il 2025 delineano un ulteriore peggioramento: nei primi sette mesi del nuovo anno il tasso medio di fecondità è stimato a 1,13 figli per donna, con minimi storici in Sardegna (0,86) e conferme solo in alcune realtà come Bolzano, Trento e Valle d’Aosta.
Sempre più figli fuori dal matrimonio
Accanto alla diminuzione delle nascite, l’Istat mette in evidenza un cambiamento sociale ormai consolidato: la crescente diffusione dei figli nati fuori dal matrimonio. Nel 2024 sono stati 159.671, pari al 43,2% del totale, una quota in aumento rispetto al 2023 (+0,8 punti percentuali) e più che raddoppiata rispetto al 2008.
Nonostante la flessione complessiva delle nascite, l’incidenza dei bambini nati da coppie non coniugate è in continua crescita. In parallelo, i nati da coppie sposate sono scesi a 210.273 (-4% rispetto all’anno precedente). Aumentano in particolare le nascite da genitori che non sono mai stati coniugati, passate dal 35,9% del 2023 al 36,9% nel 2024.
Le differenze territoriali in questa statistica restano marcate ma si stanno riducendo. La quota più alta si rileva nel Centro (49,6%), seguito dal Nord (42,8%) e dal Mezzogiorno (40,3%), dove però il dato è in costante crescita. La Sardegna si conferma la regione con la maggiore incidenza (56,6%), mentre i valori più bassi si registrano in Basilicata (30,0%) e Calabria (33,4%).
La tendenza, inoltre, riguarda soprattutto i più giovani: il 61,7% delle madri under 24 e il 43,6% di quelle tra 25 e 34 anni ha avuto figli fuori dal matrimonio. Tra le coppie di soli italiani le percentuali salgono ulteriormente, segno di una progressiva ridefinizione dei modelli familiari. L’85,6% delle nascite more uxorio, infine, proviene da genitori entrambi celibi e nubili.
Nomi e preferenze dei genitori
Nel 2024 Leonardo si conferma il nome maschile più scelto dai genitori italiani, mantenendo il primato in tutte le regioni del Nord e in parte del Centro. Edoardo e Tommaso completano il podio, mentre Francesco scende al sesto posto.
Tra le bambine, la classifica rimane invariata: Sofia si conferma il nome più amato, seguita da Aurora, Ginevra, Vittoria e Giulia. Nelle regioni del Mezzogiorno, però, le scelte sono più diversificate, con predominio di nomi come Aurora in Sicilia e Campania, Giulia in Basilicata e Ginevra in Calabria.
Tra i figli di genitori stranieri, i nomi più diffusi sono Rayan, Adam e Amir per i maschi e Sofia, Sara e Amira per le femmine. Le comunità romena e albanese mostrano tendenze differenti: i romeni adottano spesso nomi italiani come Matteo e Luca, mentre tra gli albanesi prevalgono nomi della tradizione d’origine.
Cresce la diffusione del doppio cognome
L’Istat dedica infine un approfondimento alla recente evoluzione nella scelta di attribuire anche il cognome materno ai figli, in linea con la sentenza della Corte costituzionale del 2016.
Nel 2024 i nati registrati con il doppio cognome sono il 6,7% del totale, un valore più che raddoppiato rispetto al 2020. La pratica è più diffusa nel Centro-Nord (8,6% al Nord e 8,3% al Centro) rispetto al Mezzogiorno (6,4%).
Il doppio cognome è adottato più spesso per i primi figli (9,2%) e nelle coppie non coniugate (8,5%). Le differenze emergono anche per cittadinanza: le coppie miste con madre italiana e padre straniero mostrano la percentuale più alta (14,1%), mentre solo il 5,2% dei nati da genitori entrambi stranieri riceve entrambi i cognomi.
Nelle famiglie di origine latinoamericana, dove la doppia denominazione è tradizionale, la quota tocca quasi il 90%, segno di una consuetudine culturale mantenuta anche in Italia.