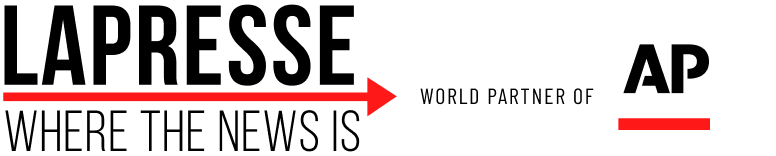di Chiara Battaglia
Torino, 9 ott. (LaPresse) – Né papa Francesco né Angela Merkel. A sorpresa il Nobel per la Pace del 2015 va in Tunisia, al Quartetto tunisino di dialogo nazionale. Motivazione: “per il suo contributo decisivo alla costruzione di una democrazia pluralistica in Tunisia sull’onda della Rivoluzione dei gelsomini del 2011″, spiega il Comitato norvegese del Nobel. Con questa scelta si mette la Tunisia al centro dell’attenzione internazionale non per il terrorismo, come è stato quasi esclusivamente di recente a seguito dei due attacchi al museo del Bardo il 18 marzo e a Sousse il 26 giugno, ma per la sua transizione democratica avviata dopo la rivoluzione con la quale nel 2011 fu cacciato Ben Ali.
È un premio ma anche un monito: si premia il Quartetto che, intervenendo “quando il processo di democratizzazione rischiava di crollare per gli omicidi politici e lo scontento sociale”, ha “stabilito un processo politico pacifico alternativo in un momento in cui il Paese era sull’orlo della guerra civile”; ma allo stesso tempo il Comitato del Nobel riconosce che la Tunisia vive un momento di difficoltà e, con questo riconoscimento a un gruppo di dialogo e concertazione, incoraggia il primo Paese da cui partirono le Primavere arabe a puntare sulla strada della democrazia. “La Tunisia affronta significative sfide politiche, economiche e di sicurezza”, scrive il Comitato norvegese del Nobel, aggiungendo che “spera che il premio di quest’anno contribuirà a salvaguardare la democrazia in Tunisia e sarà un’ispirazione per tutti coloro che vorranno provare a promuovere pace e democrazia in Medioriente, Nord Africa e nel resto del mondo”.
Quali difficoltà affronta la Tunisia? Da una parte il problema del terrorismo e di come la gestione della sicurezza si possa conciliare con i principi democratici: con circa 3mila volontari secondo le cifre ufficiali e oltre 5mila secondo esperti indipendenti, i tunisini costituiscono la prima nazionalità di combattenti stranieri tra le file dell’Isis; lo stato d’emergenza introdotto il 4 luglio dal presidente Beji Caid Essebsi a seguito degli attacchi a Bardo e Sousse è stato in vigore fino al 2 ottobre ed è solo di ieri la notizia dell’attentato contro il deputato di Nidaa Tounes Ridha Charfeddine. Dall’altra la gestione del processo democratico e i conti con il passato: solo per fare un esempio, ha recentemente sollevato un’ondata di proteste guidate dal movimento ‘Io non perdono’ la proposta di una legge di ‘amnistia fiscale’ o ‘riconciliazione economica e finanziaria’, che in sostanza perdona coloro che si sono arricchiti illegalmente durante la dittatura di Ben Ali per permettere, secondo la versione della presidenza, che i tunisini che hanno i soldi tornino a investire in Tunisia. Dall’altra parte ancora le istanze disattese portate avanti dai martiri della rivoluzione, la corruzione, i casi di soprusi e tortura da parte delle forze dell’ordine che ancora si verificano. E tutto questo in una situazione economica non rosea, con disoccupazione alta e settore del turismo che, un tempo pilastro dell’economia tunisina, è crollato dopo la rivoluzione e ha subìto un tracollo negli ultimi mesi a seguito degli attacchi terroristici di Bardo e Sousse.
Ma cos’è il Quartetto? Cosa ha fatto e perché è stato premiato? Il Quartetto è composto da quattro organizzazioni della società civile: Lega tunisina per i diritti dell’uomo (Ltdh), sindacato Ugtt, ordine degli avvocati tunisini e confederazione Utica che unisce rappresentanti di industria, commercio e artigianato. Si è formato nell’estate del 2013, dopo gli omicidi di due politici del movimento di opposizione Fronte popolare, Chokri Belaid ucciso il 6 febbraio del 2013 e Mohammed Brahmi assassinato il 25 luglio dello stesso anno (nel giorno della festa della Repubblica).
La situazione in quel momento era la seguente: la rivoluzione e la cacciata di Ben Ali del 2011 avevano lasciato il posto a un’Assemblea costituente e a un governo scelti democraticamente con le elezioni di ottobre 2011 e a guidare il Paese era la cosiddetta troika, una coalizione composta dal partito islamista Ennahda, Congresso per la repubblica (Cpr) ed Ettakatol.
Ma timori e proteste contro Ennahda erano frequenti e dopo gli omicidi politici monta lo scontento contro il governo, accusato di non essere in grado di garantire la sicurezza e, da alcuni, di essere addirittura il mandante politico delle uccisioni. È crisi politica: per protestare contro l’omicidio Brahmi e contro il governo ritenuto responsabile di una enorme falla nella sicurezza, alcuni deputati si ritirano dall’Assemblea. È a questo punto che subentra il Quartetto: in questa situazione di stallo il presidente del Parlamento, Mustapha Ben Jafaar, decide di non ricorrere al meccanismo che prevedeva la sostituzione dei deputati ritirati, ma fa entrare in scena il Quartetto nazionale, incaricato di risolvere l’impasse.
“In quella concertazione, che si svolse a lato del governo e a lato anche dell’Assemblea costituente, fu concordata una roadmap che prevedeva le seguenti cose: i deputati accettavano di rientrare per terminare la stesura della Costituzione e successivamente il governo si sarebbe dimesso a vantaggio di un esecutivo tecnico”, come ricordava l’anno scorso in un’intervista a LaPresse Chiara Sebastiani, insegnante di Teoria della sfera pubblica e politiche locali e urbane all’università di Bologna ed esperta di Tunisia. Ed è stato proprio il governo tecnico di Mehdi Jomaa a portare la Tunisia alle elezioni del 2014, quelle grazie alle quali è stato scelto il primo Parlamento democraticamente eletto del Paese (nelle elezioni del 2011 infatti era stata scelta un’Assemblea costituente, non un Parlamento).
Il Quartetto ha continuato a giocare un ruolo anche dopo l’impasse sorta con gli omicidi politici. L’anno scorso per esempio, con la doppia tornata elettorale del 2014 in cui si sono svolte legislative e presidenziali, dal momento che l’Assemblea costituente aveva stabilito che le presidenziali si sarebbero tenute dopo le legislative (per il Parlamento si è votato il 26 ottobre e per il presidente si è votato il 23 novembre e poi il 21 dicembre per il secondo turno), si era posto il problema di quale presidente avrebbe dovuto nominare il nuovo governo, se il presidente uscente Marzouki oppure quello che sarebbe stato eletto dopo. I costituzionalisti si erano spaccati su questa questione e a decidere era stato proprio il Quartetto, stabilendo che la nomina sarebbe spettata al nuovo presidente. Il Quartetto nazionale è stato “strumentale per permettere alla Tunisia, nell’arco di pochi anni, di stabilire un sistema costituzionale di governo garantendo diritti fondamentali per l’intera popolazione, indipendentemente da genere, convinzioni politiche e credo religioso”, afferma il Comitato dei Nobel.