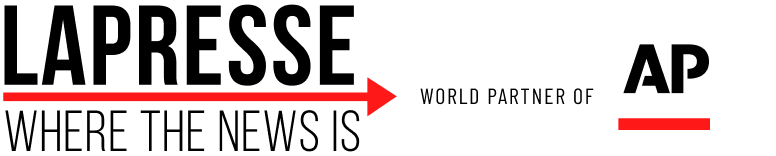Il faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin apre di fatto la strada ai negoziati per mettere fine al conflitto ucraino. L’incontro non sarà risolutivo ma l’inizio di un percorso accidentato e per niente facile. Per capire come potrebbe evolversi la situazione occorre ripercorrere i fili della matassa della questione ucraina, capire cosa non ha funzionato in passato e immaginare i possibili scenari alla luce del contesto politico attuale.
Questa volta, rispetto agli accordi di Minsk di dieci anni fa, dove non erano coinvolti gli Usa, la portata geopolitica è molto più ampia. Il conflitto ucraino è diventato per l’Europa una questione vitale per le minacce alla sua sicurezza che ha scatenato la corsa al riarmo. Strappare un buon accordo è pertanto mettere un argine alle mire imperialiste russe sul continente europeo, ma non solo. Il conflitto ha coinvolto infatti anche i Paesi terzi, con gli alleati dell’uno e dell’altro schieramento.
L’incontro di Anchorage, in Alaska, non sarà una nuova Jalta, la conferenza tra Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt e Iosif Stalin che nel 1945 definì l’assetto post-bellico, anche perché nel frattempo le due Superpotenze sono diventate rivali, ma i due leader vorranno affrontare questioni più ampie: il Cremlino vuole sfruttare il momento per toccare temi relativi alla dottrina nucleare e alla sicurezza globale, gli Usa potrebbero anche giocare la carta della leva economica e dello sfruttamento delle materie prime critiche anche in Alaska.
La guerra del Donbass
Il primo conflitto Ucraina-Russia è la guerra del Donbass del 2014, iniziata dopo la rivolta di Maidan, esplosa a Kiev nel novembre 2013. Le manifestazioni, incentrate in piazza Indipendenza (Maidan Nezaležnosti), nacquero dalla decisione del presidente Viktor Yanukovych di sospendere l’accordo di associazione con l’Ue, optando per legami più stretti con Mosca, e poi si trasformarono in un movimento di massa per la democrazia e contro la corruzione.
Dopo mesi di scontri, culminati a febbraio 2014 con decine di morti, Yanukovych fuggì in Russia, aprendo la strada a un nuovo governo filoccidentale e innescando la crisi con Mosca. La guerra del Donbass, iniziata nel 2014 dopo l’annessione della Crimea da parte della Russia, vede contrapposti esercito ucraino e separatisti filorussi nelle regioni di Donetsk e Luhansk. Il conflitto ha causato migliaia di morti e spostamenti di popolazione, diventando terreno di tensione tra Mosca e l’Occidente.
Evitare il flop degli accordi di Minsk
Gli accordi di Minsk, firmati nel 2014 e 2015, nacquero per porre fine alla guerra nel Donbass. Il primo protocollo, Minsk I, negoziato da Ucraina, Russia e OSCE, prevedeva cessate il fuoco e monitoraggio internazionale, ma i combattimenti continuarono. Il fallimento portò alla mediazione di Francia e Germania con il ‘Formato Normandia’, da cui nacque Minsk II nel febbraio 2015. Il protocollo conteneva 13 punti, tra cui ritiro di armi pesanti, scambio di prigionieri, accesso agli aiuti, riforma costituzionale e autonomia per Donetsk e Lugansk.
L’attuazione fu difficile: violazioni quotidiane, restrizioni agli osservatori OSCE e lentezza negli scambi di prigionieri. Mosca chiedeva prima le misure politiche, Kiev quelle militari, creando uno stallo. Alcuni progressi arrivarono nel 2019, ma status speciale ed elezioni locali rimasero irrisolti. La Russia si presentava come mediatrice, mentre Kiev la accusava di occupazione indiretta. Alla vigilia dell’invasione russa del 2022, gli accordi erano bloccati e privi di prospettive concrete. Secondo alcuni analisti, potevano essere base di compromesso, ma le posizioni restavano inconciliabili.
Trattato o soluzione ‘coreana’?
Attualmente, entrambe le parti mantengono obiettivi inconciliabili: l’Ucraina chiede il ritiro totale delle truppe russe e il ripristino dei confini del 1991; la Russia rivendica il controllo delle aree annesse (Donetsk, Lugansk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimea) e garanzie di neutralità di Kiev.
L’ipotesi ‘trattato‘ evocata da Tajani. Il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani ha parlato di un possibile ‘trattato di pace’ che implichi una soluzione negoziata, riconosciuta a livello internazionale, con impegni vincolanti per entrambe le parti. Un accordo di questo tipo potrebbe prevedere: cessate il fuoco verificato da osservatori internazionali; ritiro parziale o totale delle forze russe; status politico definito per le regioni contese (autonomia o amministrazione speciale); garanzie di sicurezza per Kiev (eventualmente con un sistema di garanti internazionali); impegni sul non ingresso dell’Ucraina nella NATO in cambio di protezione multilaterale. Sarebbe un documento formale, con clausole precise e tempistiche, simile agli accordi di Dayton per la Bosnia.
La ‘soluzione coreana’ e la questione dei territori
Il capo della Casa Bianca sostiene che ci sarà ‘uno scambio di territori‘ tra Kiev e Mosca. Di certo, dovrà coinvolgere – e convincere – la leadership ucraina. Per questo, se l’incontro andrà bene, ci sarà un nuovo vertice a tre, anche con Zelensky. Il cancelliere tedesco Merz e il presidente ucraino hanno parlato di un congelamento dell’attuale linea del fronte ma senza alcun riconoscimento formale di cessioni territoriali alla Russia. Una proposta che richiama l’esempio coreano. Ispirata all’armistizio del 1953 tra le due Coree, la soluzione coreana non sarebbe un vero trattato di pace ma un cessate il fuoco permanente senza risolvere la disputa territoriale.
In pratica, si congelerebbe il fronte attuale con una linea di demarcazione militarizzata, controllata da forze internazionali, lasciando aperte le rivendicazioni di sovranità. L’Ucraina manterrebbe il controllo sulle aree oggi sotto la sua amministrazione, la Russia sulle zone occupate, ma senza riconoscimento giuridico reciproco. Per l’Ucraina, però, si tratterebbe di un compromesso delicato: la Costituzione vieta la cessione di territori senza un referendum nazionale, ma uno ‘stallo congelato’ potrebbe permettere di aggirare temporaneamente la consultazione popolare, continuando a rivendicare formalmente Crimea, Donbass e altre aree attualmente occupate. È una soluzione che eviterebbe ulteriori perdite umane, ma sancirebbe una divisione de facto del Paese. Non solo, la soluzione non risolverebbe le questioni politiche di fondo e contrasterebbe con il mantra dei partner occidentali di volere una ‘pace giusta e duratura’, ovvero una soluzione stabile e definitiva.
Il nodo dell’adesione alla Nato
Durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti lasciarono intendere a Mosca che la NATO non si sarebbe espansa verso Est, senza però formalizzare alcun impegno scritto. Con la fine dell’URSS nel 1991, diversi ex satelliti sovietici cercarono protezione nell’Alleanza. Nel 1997, l’Atto Fondativo NATO-Russia confermò l’assenza di ‘piani’ per basi permanenti nei nuovi membri, senza escludere l’allargamento.Il primo ampliamento post-Guerra Fredda arrivò nel 1999 con Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca; nel 2004 entrarono Estonia, Lettonia, Lituania, Bulgaria, Romania, Slovacchia e Slovenia. Per Mosca, l’ingresso dei Baltici violò una ‘linea rossa’ strategica.
L’Ucraina, indipendente dal 1991, restò inizialmente neutrale, ma nei primi anni 2000 avviò un avvicinamento alla NATO. Al vertice di Bucarest del 2008, l’Alleanza dichiarò che l’Ucraina e la Georgia sarebbero diventate membri, senza fissare tempi né un Membership Action Plan, a causa delle resistenze di Berlino e Parigi. Dopo l’annessione russa della Crimea nel 2014, Kiev rafforzò i legami militari con la NATO e nel 2019 inserì l’obiettivo dell’adesione nella Costituzione. Pur sostenendo il diritto ucraino di scegliere le proprie alleanze, l’Alleanza non ha mai avviato un percorso rapido di ingresso. Mosca ha chiesto garanzie legali per escludere Kiev, ma la mancanza di un accordo è stata una delle tensioni che hanno preceduto l’invasione del 2022.
Le garanzie di sicurezza
La questione delle garanzie di sicurezza scaturisce dalla necessità di proteggere l’Ucraina – ma anche altri paesi dell’Est europeo – da futuri attacchi e invasioni russe. Il governo di Kiev ritiene che l’unica vera garanzia sia la piena adesione alla Nato, con l’obbligo per gli alleati sancito dall’articolo 5 del Trattato nord-atlantico di intervenire in caso di attacco. L’adesione non è all’ordine del giorno essendo una linea rossa per Mosca. Zelensky e altri leader occidentali ritengono però che non spetti alla Russia decidere su una scelta i un paese sovrano e dei membri dell’Alleanza.
Nel luglio 2023, a margine del vertice Nato di Vilnius, i Paesi del G7 hanno emesso una ‘Dichiarazione su garanzie di sicurezza‘ verso Kiev e stretto accordi bilaterali non vincolanti ma pluriennali. Tra le garanzie, i leader della coalizione dei Volenterosi, in particolare Francia e Gran Bretagna, avevano proposto di inviare delle ‘forze di rassicurazione’, un contingente multinazionale, una volta siglata la tregua, come protezione del Paese, non in prima linea, dove resterebbero gli ucraini, ma in una fascia più interna. Trump, che in un primo momento si era sfilato dal fornire ulteriore sostegno a Kiev, nei colloqui del 13 agosto con i leader europei avrebbe garantito la disponibilità degli Usa di condividere con l’Europa le garanzie di sicurezza post-belliche per l’Ucraina.
La proposta di Meloni
L’Italia ha detto che non avrebbe mandato soldati a Kiev. La premier Giorgia Meloni ha avanzato invece l’idea di estendere la protezione dell’articolo 5 della Nato all’Ucraina, in tal modo Kiev sarebbe protetta anche senza essere membro dell’Alleanza. Resta da capire come attuarla.
L’adesione all’Ue non prima del 2030
Per l’Ucraina c’è sempre la strada dell’adesione all’Unione europea, una prospettiva che non dà più fastidio a Mosca come ai tempi delle rivolte di Maidan. Il Trattato dell’Ue, all’articolo 42.7, prevede una clausola di difesa reciproca, finora mai attivata, secondo cui ‘qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite’. In ogni caso, non ci sarebbe l’intervento Usa ed è difficile che l’adesione di Kiev all’Ue avvenga prima del 2030. Al momento l’apertura dei capitoli negoziali è bloccata dall’Ungheria, ma il lavoro va avanti, anche in prospettiva di un cambio di governo a Budapest.