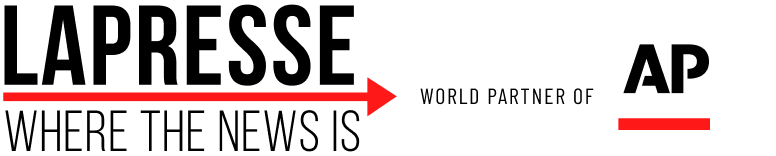Prima notte sulla ciminiera a oltre 100 metri d’altezza per i quattro lavoratori della Portovesme srl, da ieri asserragliati sulla torre e che hanno iniziato oggi il secondo giorno di protesta in attesa dell’esito dell’incontro convocato dal governo. In mattinata è prevista un’assemblea nella fabbrica del Sulcis, in Sardegna. Da oggi la cassa integrazione viene estesa a gran parte dei dipendenti e degli appalti, mentre gli interinali sono a casa.
La questione del caro energia
Gli operai sono saliti sulla torre ieri chiedendo un incontro urgente col ministero delle Imprese a Roma per risolvere il problema del caro energia. Dopo il rinvio della discussione sul Decreto energia, infatti, la Regione non aveva ancora comunicato ai sindacati le contromisure da adottare per salvaguardare l’attività delle imprese e gli stessi programmi di investimento messi seriamente a rischio. L’ultimo incontro tra l’azienda e i sindacati, insieme alla Regione, risale a gennaio: da allora ci sono state diverse interlocuzioni tra la Portovesme Srl e i player dell’energia, ma non sarebbe stato raggiunto l’accordo per un contratto di fornitura di energia a prezzi sostenibili. Da questo è derivata l’estensione della cassa integrazione per i dipendenti della società.
La lunga storia di una crisi
La storia della crisi di questa fabbrica inizia però da lontano. È il 2012 quando l’Alcoa decide di fermare gli impianti e lasciare a casa centinaia di famiglie. Nel 2018 una nuova società, la Glencore, rileva lo stabilimento con l’intervento di Invitalia. Si pensa di ripartire nel 2020 ma subentrano problemi burocratici. E così si arriva al dicembre del 2022 con l’entrata in funzione del nuovo forno. È solo una prima fase. La vera sfida è far ripartire la sala elettrolisi. Ma la società attende che le banche sblocchino nuovi finanziamenti. Ora l’obiettivo è quello di scongiurare i piani della Glencore che vuole fermare la produzione del piombo negli impianti di San Gavino e Portovesme, mandando in cassa integrazione altri 200 lavoratori, che si aggiungerebbero ai 300 già in cassa integrazione da un anno per lo stop alla linea dello zinco. La storia di Portovesme è figlia delle miniere, della loro espansione e del loro fallimento. La sua crisi è la conseguenza di una privatizzazione fatta in tempi rapidissimi per liberarsi del macigno di debiti e scandali rappresentato dall’Efim.
La storia dell’area nasce dalla metà del XIX secolo. La Monteponi, proprietaria delle miniere di Iglesias, doveva realizzare un nuovo porto per il trasporto dei minerali: scelse l’area di Is Canneddas, ma in onore dell’ideatore di quel porto, lo storico Carlo Baudi di Vesme, fu chiamata Portovesme. Poi le società private che detenevano le concessioni minerarie si ritirarono lasciando spazio all’intervento statale, che si orientò verso la realizzazione di un grande polo metallurgico che potesse assorbire anche i dipendenti delle miniere del Sulcis e dell’Iglesiente in fase di chiusura e che ricevesse dall’esterno, via mare, le materie prime non più estraibili in loco. Il polo industriale di Portovesme si sviluppò tra il 1969 ed il 1972 per iniziativa di due enti pubblici: l’Efim, che investi ingenti risorse in un polo dell’alluminio e l’Egam che, oltre a rilevare la gestione delle poche miniere rimaste aperte, realizzò nei primi anni Settanta gli impianti per la lavorazione del piombo e dello zinco, poi acquistati dall’Eni, con la Nuova Samim e diventati Portovesme srl. Nel 1992 la liquidazione dell’Efim e il cambio di strategia dell’Eni, che si concentrò sulla filiera del petrolio, portarono tutti gli impianti alla privatizzazione, con l’acquisizione da parte di multinazionali del settore (Alcoa e Glencore). Scelta allora approvata da tutte le parti politiche ma che lasciava irrisolti i nodi centrali dello sviluppo: una forza lavoro gonfiata, per assorbire gli esuberi dalla chiusura progressiva delle miniere, l’assenza di infrastrutture moderne, comunicazioni via mare e via terra inadeguate, e un problema di fondo legato al costo dell’energia, diventato ormai insostenibile.